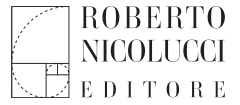Gemito. La vita, l’opera
Salvatore di Giacomo
Gemito. La vita, l’opera
a cura di Roberto Nicolucci e Laura Cannavacciuolo
Napoli, Roberto Nicolucci Editore, 2023
La si potrebbe dire una prosa di soggezione, quella del Salvatore di Giacomo biografo di Vincenzo Gemito: una soggezione devota e appassionata, ma forte e stringente, tanta era la stima che il poeta (1860-1934) nutriva per il suo amico artista (1852-1929).
Nella lettera d’ouverture (aprile 1905) indirizzata al collezionista Achille Minozzi, committente della biografia, di Giacomo non manca di esplicitare l’ammirazione fervida e ferma che nutre per il suo concittadino: «Gemito – scrive – è un maestro il cui posto è ormai nella storia dell’arte italiana: egli ha spinto la manifestazione della vita fino al suo limite estremo e le ha conferito la forma più squisita e più degna» (p. 21).
Più oltre spiegherà che lo scopo della sua biografia è quello di offrire «la documentazione dell’opera di una personalità così strana e, per una certa armonia di qualità che non si riscontrano tanto spesso, così potente e raffinata» (p. 82).
La Vita di Gemito risale al 1905 ed è stata ora “recuperata” grazie alla curatela di due studiosi molto competenti, lo storico dell’arte Roberto Nicolucci (editore e docente all’Università Guglielmo Marconi di Roma) e la storica della letteratura Laura Cannavacciuolo (docente all’Università L’Orientale di Napoli).
Il volume torna con la sua importanza di “documento” e con il suo fascino di “prova” di scrittura (e qui è il più), dove «la ricognizione patografica, l’invenzione narrativa e il racconto documentaristico» (Cannavacciuolo, p. 13) si intrecciano, si combinano e cercano un dialogo.
Sovrastato e linguisticamente soggiogato dal suo artista, di Giacomo ne racconta la vita adoperando una scrittura dal «carattere ricercato e cerimonioso», che dà corpo a «una prosa scandita da volute arcaicizzanti» e da «una sintassi ridondante e artificiosa», osserva Laura Cannavacciuolo nel suo saggio Raccontare un artista (p. 15).
Secondo un lavoro formale che si trasforma nel “tono” complessivo della biografia, la soggezione ammirata dà sostanza a un testo ibrido e mosso da un’ansia di adesione innocente e sbilanciata.
A livello strutturale, però, l’insieme è sorretto da «una solida impalcatura narrativa che, seguendo i moduli tipici della prosa digiacomiana, finisce per attribuire al personaggio Gemito alcuni dei tratti propri dei protagonisti delle sua narrativa», spiega ancora Cannavacciuolo (p. 13).
Il rilievo è fondamentale e rimette in primo piano la consistenza intimamente “laboratoriale” della biografia: di Giacomo trapianta Gemito nel proprio mondo in quanto ogni soggezione positivamente vissuta presuppone e comporta moti di appropriazione, anche inavvertiti.
Prende così forma un «oggetto liberty un poco difficile da maneggiare», ma che offre certamente un’incursione affascinante nella vita di un artista «classico e caravaggesco; istintivo e ineducabile; accademico e indisciplinato, diffidente e irriducibile; antico e moderno», in altre parole «un diamante pazzo», come scrive acutamente Nicolucci nel saggio di apertura Da un poeta all’altro (pp. 5 – 7).
In Gemito lo stile digiacomiano è tanto accentuato nelle movenze, e tanto calcato nell’incedere, da lasciar ipotizzare – sia pure a rischio d’illazione – una non risolta indecisione di fondo, nell’autore, circa la via da percorrere: se quella schiettamente divulgativa, se quella più rigida e didascalica, se il racconto critico, se il ritratto dal valore testimoniale, se la memoria personale, se la riflessione su un’epoca fatta mediante il vissuto di un artista.
Valga come prova, fra tutti, un brano nel quale pare di percepire lo sforzo compiuto da di Giacomo per tenere assieme, comprimendoli, livelli fra loro distanti quando non divergenti: «Gemito è un uomo che ha molto lavorato, molto amato, molto sofferto. E sulla sua natura sensibile, incline a una quasi morbida valutazione degli avvenimenti anche più comuni, una serie di fatti impressionanti ha in questi ultimi anni scavato tal solco che oramai non è più possibile colmare. Essi hanno trovato in quello spirito acceso il terreno propizio a una germinazione di concetti subitanei e già quasi incoerenti, d’apprezzamenti esagerati, d’esaltazioni, di pregiudizii, una gran parte de’ quali, se non mi sbaglio, s’addice principalmente a’ difetti d’una cultura che non ha migliorato in tutto questo tempo e che in artisti non solamente rivolti al sistematico per quanto sincero e scrupoloso studio del vero è una seconda e provvida indagine se non è pur una seconda natura e un imperioso bisogno» (p. 105).
Non va dimenticato che, all’epoca, di Giacomo era in «una fase nuova della sua attività letteraria, quando al progressivo esaurirsi della vena poetico-narrativa andava aggiungendosi una rinnovata dedizione per studi storico-eruditi» (Cannavacciuolo, p. 11).
Si può pertanto pensare che la sua prosa di soggezione fosse allora connessa con una più sfumata e ampia situazione di verifica, di riassetto, di cambiamento, di verosimile incertezza, in definitiva di crisi.
Resta fermo che, al di là delle opzioni adottate, la destrezza diegetica digiacomiana offre pagine notevoli, come quella ove viene immaginato uno dei momenti cruciali della difficile, tormentata, aspra vita di Vincenzo Gemito: la notte in cui il suo «picciol corpicciolo» di neonato viene abbandonato nel «triste ospizio» degli orfani.
Di Giacomo ricrea la scena con un drappeggio che vira verso il patetico, ma nel quale si coglie anche una sapienza “visuale” che oggi diremmo cinematografica: «S’agitava al lume della lampa ad olio quella minuscola e rosea nudità e palpitava: il pargolo, pieno di vita, con gli occhi spalancati, traeva forte il respiro e vagiva» (p. 25).
La nuova edizione di Gemito. La vita, l’opera si chiude con il saggio di Raffaello Causa (1923-1984) Ritorno a Gemito.